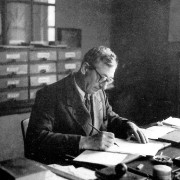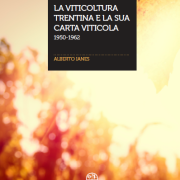La storia della Carta Viticola
Nel secondo dopoguerra la viticoltura trentina, pur in presenza di qualche segnale di ripresa, rimaneva un settore produttivo fragile, così come era tutta da costruire la conquista dei mercati vinicoli nazionali e internazionali.
Precise indicazioni sui passi da compiere per ammodernare il settore erano state fornite tra gli anni Venti e Trenta da esperti come Tranquillini, Juffmann e Rigotti, con un primo studio sistematico della viticoltura trentina pubblicato nel 1931 su Esperienze e ricerche (link), il periodico della Stazione sperimentale di S. Michele. Essi suggerivano le strategie più adatte per sostenere il miglioramento dei vitigni e del processo di vinificazione: la formazione continua degli operatori agricoli, la necessità d’incentivare la coltivazione solo in zone vocate, il potenziamento della cooperazione viticola e la maggiore cura promozionale, specie sui mercati esteri.
Il Comitato vitivinicolo provinciale, costituito nel 1949 presso la Camera di commercio, aveva promosso il terzo grande rinnovo postfillosserico, orientando i viticoltori verso alcune tipologie di varietà di qualità, più richieste dal mercato. Lo sforzo profuso, tuttavia, non raggiungeva rapidamente i risultati sperati; una serie di vincoli strutturali (estrema variabilità delle condizioni ambientali, condizionamenti orografici, eccessiva frammentazione della proprietà agraria, costi di produzione più elevati) evidenziavano la minor competitività del Trentino rispetto ad altre regioni italiane e rischiavano di bloccare il processo di miglioramento della qualità.
Il Comitato vitivinicolo si fece carico della situazione, decidendo di realizzare un’indagine conoscitiva approfondita del settore, capace di descrivere analiticamente lo stato di ciascuna area viticola, premessa indispensabile per formulare poi nuovi indirizzi di sviluppo e miglioramento tecnico, varietale e produttivo, in funzione anche delle propensioni dei singoli territori e delle mutate esigenze dei consumatori. Fu naturale conferire l’incarico di realizzare il progetto alla Stazione Sperimentale dell’Istituto agrario di San Michele, individuando in particolare in Rebo Rigotti, in virtù della dalla pluridecennale esperienza nel settore, il referente esperto e affidabile.
Nacque così il progetto della Carta viticola del Trentino che, nelle parole di Rigotti, intendeva conoscere la viticoltura provinciale «1) nella sua diffusione secondo un criterio geografico e pedologico; 2) nella distribuzione topografica delle varietà viticole regionali e varietà straniere importate; 3) nella sua produzione media annuale attuale, quantitativa e qualitativa, per zone e vitigni; 4) nelle sue caratteristiche colturali ed ecologiche per zone viticole; 5) nella sua importanza economico-rurale per Comune e nella sua consistenza patrimoniale globale».
Lo stesso Rigotti mise in campo un metodo “originale” di lavoro: esso prevedeva l’individuazione di appositi informatori comunali, persone affidabili che ben conoscessero la realtà del Comune viticolo catastale di loro pertinenza e fossero in grado di raccogliere e fornire tutte le informazioni necessarie a compilare schede e registri predisposti allo scopo, assieme alle schede e carte topografiche, che descrivevano ciascuna zona.
Si evidenziava subito, dunque, la duplice natura della Carta viticola: da un lato, essa assumeva una valenza conoscitiva, una mappa della consistenza e dello stato di salute della viticoltura trentina. Dall’altro lato, la Carta viticola diventava strumento di lavoro e finalizzato alla stesura del nuovo “indirizzo viticolo provinciale”.
Impostazione e realizzazione del progetto
Come sottolineato da Rebo Rigotti, il lavoro richiese uno sforzo d’”impostazione piuttosto complesso”, e si avvalse della base metodologica già utilizzata nel saggio Rilievi statistici e considerazioni sulla viticoltura trentina del 1931. Si trattò di isolare «un sistema pratico di registrazione dei dati e un metodo di effettuare i rilevamenti sul luogo in modo da raggiungere la massima attendibilità sui dati stessi»”(Rigotti, 1955, p. 277).
Durante la fase preparatoria, Rigotti compì una ricognizione geografica sulla viticoltura trentina: individuò cinque vallate a maggiore densità viticola e cinque, invece, in cui il settore aveva un peso decisamente inferiore. Rientravano nel primo gruppo di vallate viticole la Val d’Adige, da Roverè della Luna ai “Murazzi” di Besenello, la Vallagarina, dai “Murazzi” di Besenello a Borghetto di Avio, il Vezzanese che si collocava tra Sopramonte e Pietramurata (Dro). Sempre nel primo gruppo ricadeva il Basso Sarca, che da Pietramurata si spingeva fino a Riva del Garda compresa la bassa Val di Ledro, infine la Valle di Cembra situata fra il Comune di Giovo e quello di Rover-Carbonare. Le vallate a minore vocazione comprendevano il Perginese, da Civezzano a Caldonazzo, la Valsugana, da Caldonazzo a Tezze, e poi le Valli di Non e di Sole, le Giudicarie esteriori e interiori, le Valli del Leno e Folgaria. Come specificato, la suddivisione in dieci aree non rispecchiava rigorosi criteri di ordine geografico bensì precise esigenze di conduzione dell’indagine che chiedevano di escludere o includere determinati Comuni, d’accorparne altri.
Inoltre, considerato che la vite veniva coltivata a quote altimetriche diverse, Rigotti individuò ulteriori cinque “zone climaenologiche” per tener conto non solo delle diverse quote altimetriche di coltivazione, ma anche di altri fattori fondamentali, tra cui la collocazione e la natura fisicochimica dei terreni e le correnti fredde o calde cui erano esposti, gli eventi atmosferici e l’esposizione delle valli e per le quali dovevano anche essere considerati altri fattori, come l’altitudine, gli aspetti ecologici, le caratteristiche della popolazione viticola, cioè la fama goduta, in quelle aree, dalla coltivazione della vite.
Le cinque zone climaenologiche (vedi approfondimento) sono:
– la zona di pianura e fondovalle
– zona di mezza collina
– zona di collina
– zona di altipiano
– zona di mezza costa o di mezza montagna
Classificazione delle vallate viticole
| N. corr. | VALLATA | N. dei comuni | N. dei comuni in cui l’importanza economica della viticoltura è: | |||
| massima | notevole | mediocre | minima | |||
| Valli maggiori: | ||||||
| 1 | Val d’Adige | 23 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Vallagarina | 39 | 23 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Vezzanese | 19 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Basso Sarca e Val di Ledro | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Valle di Cembra | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Tot. valli maggiori | 108 | 46 | 17 | 12 | 33 | |
| Valli minori: | ||||||
| 6 | Perginese | 23 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 7 | Valsugana | 19 | – | 5 | 10 | 4 |
| 8 | Valli di Non e di Sole | 53 | – | 3 | 5 | 45 |
| 9 | Giudicarie | 23 | – | – | 2 | 21 |
| 10 | Valli del Leno e Folgaria | 4 | – | – | – | 4 |
| Tot. valli minori | 122 | 2 | 11 | 29 | 80 | |
| Totale | 230 | 48 | 28 | 41 | 113 | |
Fonte: Elaborazione dati Rigotti, 1955, p. 281.
Nelle vallate viticole, vennero identificati 230 Comuni catastali dove si coltivava la vite, appartenenti a 112 Comuni amministrativi sui 218 complessivi; essi furono distinti in quattro classi in base all’importanza economica assunta dal settore in ciascun Comune (massima, notevole, mediocre o minima)
Per ogni Comune si dovevano rilevare e registrare diversi aspetti: le superfici vitate, la produzione dei singoli vitigni e le varietà coltivate distinte per zona, alcune note sulle tecniche colturali, come l’intensità d’impianto, il sistema di allevamento, la ricostruzione su piede americano, i portinnesti, i trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, le concimazioni, le potature e le rese unitarie per ettaro. Inoltre, giudizi e valori sulle zone vitate, come la valutazione sulla qualità dei prodotti, dati tecnici su aspetti ecologici come il terreno e il clima, oltre a informazioni circa lo sbocco finale del prodotto viticolo, se conferito in cantina sociale o trattato da cantine private. Considerata la grande influenza sulla qualità delle produzioni, particolare attenzione fu riservata alla descrizione del tipo di terreno, di cui si rilevava l’origine geodinamica e litologica e si prelevavano campioni per l’analisi chimico fisica.
Un dato fondamentale ma assai difficile da determinare era la produzione unitaria per ettaro, divisa per zona e vitigno, e quella complessiva per Comune, che dovevano essere attentamente ponderate dagli informatori di zona. Le varietà coltivate , infine, si dovevano distinguere tra vitigni tradizionali e stranieri, mentre per gli aspetti di tipo economico si sarebbe dovuto attingere alle statistiche disponibili in loco.
Il materiale per la registrazione
Rigotti predispose schede dettagliate prestampate per la registrazione e l’esposizione dei dati. Per ogni Comune era prevista una cartella a tre lembi che conteneva un certo numero di prospetti per l’inserimento delle statistiche e due carte topografiche, una dedicata alla distribuzione dei vigneti, l’altra riguardante l’origine, la natura e le caratteristiche dei terreni.
La scheda principale era a doppio foglio (scheda A e scheda B), divisa in quattro campi. Ciascuno dei due fogli informazioni su produzione globale, per vitigno e per zona viticola (pianura, collina, montagna); superficie vitata complessiva e per zona; informazioni relative agli aspetti colturali ed ecologici, come il sistema di allevamento, l’intensità d’impianto, la ricostruzione su piede americano, e ancora trattamenti e concimazioni, potatura, produzione unitaria e a ettaro; un altro prospetto era dedicato alla produzione tipica qualificata, ai rilievi pedologici e al quadro climatico. Infine vi era un richiamo alla destinazione del prodotto, che poteva essere lavorato in cantina sociale o in cantina privata, esportato o venduto come uva da tavola.
Complessa e impegnativa fu la predisposizione delle carte topografiche comunali per i terreni e per i vitigni, rappresentazione delle informazioni raccolte nelle ricognizioni sul campo per gli aspetti pedologici e ampelografici. La “carta dei terreni” evidenziava con colori differenti le plaghe vitate, in base alla loro origine pedologica e litologica, mentre in calce era riportato un riquadro d’insieme del Comune dove veniva indicata la posizione del podere oggetto di rilievo, oltre che una sintetica legenda con segnati i simboli e i colori usati.
La “carta dei vitigni” veniva utilizzata per delimitare le zone altimetriche e fissare con l’uso di più colori l’ubicazione di differenti varietà di vitigni. Maggiori dettagli sono riportati nelle Note archivistiche, nella pagina di consultazione dei fascicoli comunali (Consulta la carta). L’incartamento complessivo di ciascun fascicolo comunale comprendeva ancora una relazione descrittiva della realtà viticola del Comune, in numero variabile di pagine a seconda della complessità del settore viticolo nella zona considerata.
Il corpus della Carta viticola del Trentino era completato dalla raccolta dei riassunti e dal raccoglitore contenente le matrici usate per produrre le topografie dei comuni catastali. I tre volumi di sintesi, finemente decorati con impronte di pampini e viticci dallo stesso Rebo Rigotti, servivano per la raccolta e l’elaborazione dei dati al termine del processo, riportando il riepilogo della produzione di vitigni regionali, della produzione di vitigni stranieri e delle superfici vitate oltre che dei sistemi di allevamento. Al termine del procedimento, infine, in una cartella di grandi dimensioni, anch’essa decorata, sarebbero stati raccolte le matrici delle topografie e altri materiali di lavoro.
La fase d’inventario: il rilevamento dei dati
I sopralluoghi nei singoli Comuni e il rilevamento dei dati vennero condotti da una commissione formata da Rebo Rigotti e dal segretario del Comitato vitivinicolo Ferdinando Tonon, coadiuvati inizialmente dal docente di viticoltura presso la Scuola agraria di San Michele, Valentino Curzel, poi designato ad altro incarico. La commissione visitò i Comuni catastali individuati, partendo dalle vallate più densamente viticole e concludendo con le zone a più bassa produzione sollecitando gli informatori comunali a lavorare con rigore e serietà. Per il loro reclutamento si invitarono gli uffici di ciascun Comune, a segnalare alcune persone del posto, viticoltori, tecnici e addetti ai lavori per collaborare al progetto. Gli informatori selezionati vennero formati tramite circolari sui dati e le informazioni da raccogliere e fornire. Successivamente essi parteciparono a degli incontri locali. Anche dopo la conclusione del progetto Carta viticola, gli esperti comunali furono invitati a mantenere la collaborazione con il Comitato vitivinicolo e la Stazione Sperimentale di San Michele all’Adige, per integrare o aggiornare i dati.
La rilevazione vera e propria dei dati si svolse direttamente nelle singole zone viticole, dove, in più sessioni di lavoro, la commissione tecnica incontrò il gruppo selezionato degli informatori comunali: le informazioni raccolte furono vagliate e discusse, ponderate prima di essere registrate su carta. Per i dati relativi alle produzioni e alle superfici vitate la commissione operò con molta cura, anche mediante controlli incrociati tra i dati ottenuti dalle fonti disponibili (catasto, ispettorato dell’agricoltura, cantine sociali) e quelli forniti dagli informatori, e procedendo a ulteriori sopralluoghi di verifica, ove necessario.
Le conclusioni e gli orientamenti proposti
L’insieme delle teche pieghevoli e i tre volumi con le descrizioni di sintesi costituivano il lavoro monografico della Carta viticola del Trentino, il cosiddetto “inventario”. Per completare il lavoro si pensò di accompagnare la Carta con la realizzazione di due pubblicazioni capaci di da un lato di motivarne l’origine, inquadrandola nell’evoluzione storica del settore viticolo in provincia di Trento, dall’altra di interpretarla, offrendo spunti di riflessione e di valutazione sulle azioni concrete da intraprendere per lo sviluppo del settore.
La prima s’intitolava Lo sviluppo viticolo del Trentino, un lavoro dell’agronomo Giuseppe Ruatti, la seconda monografia, Indirizzo viticolo per la provincia di Trento, era il risultato di uno scambio d’idee e di opinioni all’interno del Comitato vitivinicolo, in cui furono chiamati a confrontarsi e a discutere alcuni esperti e tecnici, in vista della definizione di indirizzi e orientamenti per il settore produttivo.
«Il problema dell’orientamento viticolo non è evidentemente nuovo» si afferma nel testo «esso è divenuto per la provincia di Trento un problema di piena attualità e di urgente necessità da quando […] il problema non fu solo e semplicemente quello di produrre, e produrre possibilmente molto, bensì di produrre vantaggiosamente, con particolare riguardo alla qualità»(Comitato vitivinicolo, 1954, p. 10). Concludendo il lavoro il Comitato vitivinicolo indicava i «postulati e le direttive tecniche per il miglioramento della produzione vitivinicola provinciale»(Comitato vitivinicolo, 1954, p. 62), elencando una serie di raccomandazioni frutto di un’analisi attenta della situazione e di un confronto d’idee fra le categorie rappresentate nel Comitato vitivinicolo (produttori, commercianti di vino e cantine sociali) ancora oggi molto pregnanti:
«Produrre meglio: La viticoltura trentina […deve] conservare il ruolo meritatamente conquistato, nel duplice intento di assicurarsi una legittima ed efficace difesa e di offrire alla viticoltura nazionale il contributo della sua crescente efficienza. Il presente lavoro indica queste mete e suggerisce la strada per toccarle, assegnando alle diverse località i vitigni adatti in una misurata e progressiva sostituzione, ove la sostituzione si giustifichi, e nella conservazione dei vitigni caratteristici, ove il carattere dalla località sia assicurato […].
Proteggere le colture elette: l’indirizzo viticolo avverte la necessità di evitare infiltrazioni di vitigni estranei a quelli che per virtù di condizioni d’ambiente particolari, hanno assunto una inconfondibile personalità. Superfluo rilevare che mai si penserà di sostituire anche solo in parte questi vitigni con altri di qualità inferiore […].
Caratterizzare il prodotto: va da sé che le qualità elette posseggono già caratteri individuali inconfondibili e che non occorre intervenire con eccezionali provvedimenti per stimolare oltre il normale i caratteri dell’origine. Ma la gamma ricchissima delle varietà di uve sparse nel Trentino, se ha in sé la risorsa animatrice delle graduazioni e delle sfumature, reclama la presenza bonificatrice dei vini “caratterizzatori”, per accentuare e porre in più chiara evidenza gli aspetti inconfondibili dell’origine […].
Potenziare il collocamento del prodotto: il Comitato è concorde nel considerare come non basti migliorare qualitativamente la produzione per assicurare il successo della viticoltura, essendo pacifico che le sorti di questa sono strettamente legate e condizionate dalle sorti del collocamento del prodotto. Si tratta perciò di due settori interdipendenti legati da una comune sorte. Occorrerà pertanto che ad un miglioramento del settore produttivo corrisponda un miglioramento del settore preposto al collocamento del prodotto e viceversa […].
Intensificare l’assistenza ai viticoltori – Sviluppare la sperimentazione viticola: il viticoltore trentino gradisce l’assistenza dei tecnici e segue con interesse i corsi che l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura organizza nei centri viticoli in collaborazione con altri Enti locali. Queste ed altre molteplici iniziative in corso da parte dell’Ispettorato Agrario, troveranno sicuramente un proficuo punto d’incontro con le consuete, tradizionali attività dell’Istituto agrario e Stazione Sperimentale di S. Michele all’Adige in modo che il frutto del patrimonio scientifico, animato dall’attività dei due organismi, maturi sul terreno delle pratiche realizzazioni a contatto diretto coi viticoltori in una sempre più intensa fioritura di iniziative. L’istituto di S. Michele, anche per le possibilità dei mezzi tecnici a sua disposizione e per quelli maggiori che sapesse darsi, è visto dal settore vitivinicolo […] in funzione di “pilota” ed ecco perché appare legittima l’aspirazione di vederlo sempre ulteriormente potenziato, onde lo stesso possa pienamente assolvere a questi vasti e complessi compiti che derivano dalle sue stesse finalità istitutive. Ma l’assistenza tecnica e l’ausilio della sperimentazione non può bastare ad assicurare la realizzazione dell’indirizzo viticolo auspicato; occorre, a nostro avviso, che l’Ente Regione, soccorra attraverso opportuni e operanti provvedimenti di legge che contemplino la possibilità di erogazioni di adeguati contributi e agevolazioni a favore del settore in genere [… e in particolare per sostenere] 1) il concorso nelle spese di acquisto delle barbatelle e parzialmente nelle spese straordinarie di impianto delle zone collinari. 2) l’incremento di corsi di istruzione tecnica. 3) l’istituzione di vigneti sperimentali a scopi orientativi e al contempo dimostrativi in tutte le zone. […].
Collaborazione in seno al Comitato Vitivinicolo Trentino […]. È infatti conciliando necessità dei produttori con esigenze dei consumatori, esperienza dei commercianti e di cantine sociali con competenza di tecnici, aspirazione di operatori con possibilità economiche, giuridiche, politiche di autorità regionali e nazionali, che il settore vitivinicolo riuscirà a creare le condizioni necessarie a un domani protetto dai pericoli che i vitivinicoli paventavano.» (Comitato vitivinicolo, 1954, pp. 63-68).
Queste parole illustrano il significato vero della Carta viticola come “piano regolatore”, ma anche come “carta viva” per l’intera viticoltura trentina. L’aggiornamento annuale previsto venne effettuato sistematicamente fino alla Revisione generale del 1962.
Sintesi tratta dal volume di Alberto Ianes “La viticoltura trentina e la sua Carta viticola” (2015) cui si rinvia per una completezza d’informazione. (link al libro)